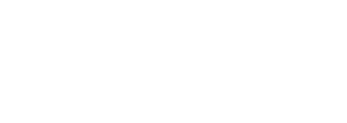APOCRIFA – Terra nostra

Mese dopo mese è ritornato l’appuntamento annuale della Conferenza delle Parti sul clima (COP), giunta alla trentesima edizione e iniziata il 10 novembre a Belém, capitale dello Stato del Parà, Amazzonia, in Brasile.
La combinazione numerica indica, per quello che vale, che sono trascorsi 20 anni dal Protocollo di Kyoto e 10 anni dall’Accordo di Parigi con un risultato importante quasi certamente mancato (il contenimento del riscaldamento a +1,5 C) e la prova, empiricamente provata, degli ultimi anni più caldi mai registrati (da quando avvengono le registrazioni, s’intende) ovunque caratterizzati da eventi naturali estremi in aumento.
Da un lato decenni di proclami e promesse altisonanti che sovente hanno velato bugie, inadempienze e contrasti irrisolti e, dall’altro, necessità evidente di azioni concrete essendo ragionevole che più se ne protrae la realizzazione, più difficile si presenta l’impresa anche a motivo del (nel frattempo) avvenuto peggioramento del contesto.
A differenza delle precedenti COP, che avevano tematiche uniche, il paese ospite aspira oggi a fare realizzare non tanto l’approvazione di nuove dichiarazioni quanto a determinare impegni concreti e, in particolare, a far sì che se ne seguano poi attentamente gli sviluppi onde evitare il ripetersi delle tradizionali e ripetute inadempienze passate.
Ovviamente un siffatto orientamento pragmatico, ove effettivamente avvenisse, sarebbe ben più utile (e più serio) rispetto ai comportamenti precedenti.
Fra gli altri uno dei sei temi principali della COP30, quello della tutela di foreste, oceani e biodiversità, coinvolge da vicino e in prima persona proprio il Brasile medesimo variamente sotto contestazione e accusa da più parti per il progressivo e distruttivo sfruttamento della regione amazzonica da troppo tempo in corso e a onta (come di norma) del colore del governo in carica.
Non per nulla c’è stata una clamorosa manifestazione, volutamente anche folcloristica, di numerosi nativi organizzatisi con i rispettivi cacique (in testa Raoni, 92 anni, instancabile sebbene solitario e sfortunato difensore delle foreste) che si è presentata a Belém via fiume su canoe allo scopo di denunciare davanti a una platea internazionale -sperabilmente meno ostile e meno coinvolta, quantomeno direttamente, di quella patria nelle distruzioni- le ulteriori pendenti minacce dell’agroindustria, della estrazione mineraria e petrolifera, della deforestazione, delle infrastrutture e delle speculazioni immobiliari.
Lasciando ora la COP30 al suo complesso lavoro, e augurandoglielo buono, una non marginale considerazione riguarda l’atteggiamento dei rappresentanti delle economie più inquinanti: già al pre-vertice sul clima (6-7 novembre scorso) convocato per i più importanti capi di stato e di governo allo scopo di preventivamente rafforzarne in qualche misura l’impegno politico in vista dei lavori ufficiali, sono mancati quelli di quattro delle cinque economie più inquinanti (Stati Uniti, Cina, India e Russia) ed è poi rimasto formalmente vuoto il seggio degli USA dopo la loro uscita, per la seconda volta, dall’Accordo di Parigi all’insegna negazionista del presidente attuale.
E la Cina presenzia con un profilo bi-fronte: di massimo inquinatore e al contempo di massimo produttore al mondo di tecnologie pulite (dai pannelli solari alle batterie) con i più elevati investimenti nelle energie rinnovabili.
Va altresì notato, a prova non necessaria di rilevanti fratture politiche su temi che comporterebbero, per la loro importanza, maggiore razionalità e lungimiranza, se non approccio almeno un poco bipartizan, che il vuoto lasciato dalla delegazione della Casa Bianca è stato colmato di fatto dal governatore, ovviamente democratico, della California, Gavin Newsom, il quale peraltro non è mediatico bluff, ma rappresentante della quarta economia mondiale che ha recentemente spodestato in graduatoria il Giappone.
Basta guardare il California State Portal per valutare la portata dello scontro politico in atto senza mezzi termini: in data 12 novembre è comparsa una articolata informazione sulle invero numerose attività di leadership e di partnership del governatore alla COP30 a seguito di una premessa poco diplomatica (dal titolo What you need to know) che dice testualmente:
Mentre Donald Trump abbandona gli alleati americani e smantella la leadership federale sul clima, il governatore Newsom sta colmando il vuoto, promuovendo la California come leader globale sul clima attraverso nuove partnership con Brasile, Colombia e Cile. Queste partnership accelereranno la cooperazione internazionale in materia di innovazione e azione per il clima, rafforzando la posizione della California come nazione partner affidabile su cui contare quando Washington non riesce a guidare.
Segue un elenco di incontri bilaterali tenuti dal governatore per rafforzare le partnership della California sia nelle Americhe in materia di clima e innovazione sia altrove con una più lunga ancora e crescente lista di accordi internazionali (Memorandum of Understanding) atti a produrre risultati concreti in materia di clima con numerosi altri Paesi.
Ed è ancora altrettanto e utile considerare anche la nota che Gates ha indirizzato alla COP30, presentata sbrigativamente dalla stampa come un’entrata a gamba tesa per rompere uova nel paniere, ma forse è qualcosa di più.
Premessa che il clima sta effettivamente cambiando, Gates sostiene che è sbagliato fermarsi a immaginare e considerare solo apocalissi climatiche a breve perché l’umanità saprà adattarsi, come ha sempre fatto in condizioni materiali ben peggiori di oggi.
Il concetto in sé appare invero, sul piano empirico, un po’ ardito, ma attendibilmente fondato sulla disincantata valutazione che, il punto di non ritorno già oltrepassato spendendo il tempo in chiacchere, continuare ad avere solo questo obiettivo sia sostanzialmente inutile oltre che più dannoso anche poiché conduce a perdere di vista altre importanti tematiche che possono invece essere, allo stato, ancora raggiungibili.
Ed ecco: la povertà estrema e le malattie che opprimono milioni di persone – soprattutto le più fragili e i bambini – che muoiono per malnutrizione, condizioni di vita infime, malattie, mancanza di farmaci, di acqua, di elettricità … (le fonti fossili producono, è ben vero, emissioni nocive, ma anche progresso economico ed è stata l’energia elettrica a migliorare la esistenza occidentale, come non si stancano di eccepire gli attuali incolpati: non così ancora in tanta parte del mondo).
Se si è ben “strutturati” – argomenta Gates – tutti saremo in grado di adattarci al clima che cambia. Altrimenti pure questo fenomeno sarà pagato soprattutto da quell’umanità che fatica già oggi a sopravvivere.
Accanto o al posto (non è ben chiaro) quindi di una attenzione esclusiva per i problemi del riscaldamento globale, che distoglie l’attenzione da problemi ancora più drammatici e già presenti, due sono le strategie proposte:
la prima è insistere e progredire con l’innovazione tecnologica nei cinque settori dell’economia globale: produzione, energia, agricoltura, trasporti, edifici (Gates ha investito miliardi di dollari in queste innovazioni tecnologiche attraverso la sua piattaforma Breakthrough Energy, comprese nuove generazioni di impianti nucleari).
La seconda è adattamento: investire in tutte quelle misure atte a contenere e mitigare i danni derivanti dall’aumento delle temperature e ancora una volta la misura principale è accrescere la disponibilità economica dei paesi più poveri.
Come si vede c’è una accentuata visionarietà -tipica a volte dei filantropi e, in ispecie, dei plurimiliardari (Quando vedo un problema difficile, il mio primo pensiero è sempre ‘how can innovation help solve this’?)- senza la quale peraltro questi obiettivi rimangono, per la loro mole, estranei ovunque alla tradizionale azione dei governi parametrata sul contingente e misurata in voti che non tiene gran conto di una situazione radicalmente diversa in azioni e omissioni a opera dei padroni della terra, ma il suo valore non viene per questo meno sotto il profilo di un necessario e moralmente obbligatorio operare comunque per tendere e in ogni caso verso qualcosa di più e di meglio.
Effettivamente, ritrovando pur un minimo di buona fede, obiettivi di civilizzazione doverosamente governati da Paesi ricchi a sostegno di quelli poveri, sarebbero anche se progressivamente possibili da attuare mantenendo un minimo, anche qui, di equilibrio fra obiettivi sia climatici sia di promozione umana altrui i quali sono nei fatti latamente comuni e difficilmente separabili.
Basterebbe considerare (alla speranza non c’è mai limite) le spese oscenamente stratosferiche investite senza sosta nella corsa agli armamenti e al finanziamento delle guerre per procura e ricordarsi, ogni tanto, di quanto scritto nel Vangelo o -per chi non crede in Dio, ma in qualche misura nell’uomo- scritto altresì da consimili che comunque si rifiutarono di rimanere bruti.
LMPD