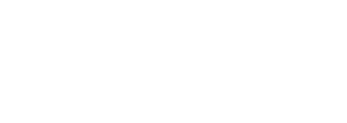DE LITTERIS ET ARTIBUS – Machiavelli
In questi giorni sui giornali leggiamo spesso che la situazione economica e politica in Francia sembra diventare sempre più simile a quella italiana. Di tale “italianizzazione” del nostro vicino d’Oltralpe ne sarebbe prova anche il “machiavellismo” riconosciuto da molti osservatori al presidente Macron, che sta gestendo con spregiudicata abilità una vera e propria girandola di primi ministri con mandati brevi e a capo di governi instabili, pur di mantenere il proprio potere.
Ciò non è del tutto nuovo: in passato, infatti, i nostri cugini francesi amavano definire il presidente Mitterrand “Le Florentin”, per sottolinearne l’intelligenza, la pazienza e la capacità di muoversi abilmente tra le insidie della politica. Era un maestro di strategia e gli veniva attribuito un approccio molto pragmatico secondo il quale ogni mezzo poteva essere utilizzato per raggiungere gli scopi desiderati.
Questi due esempi testimoniano la perdurante capacità evocativa del pensatore e letterato fiorentino Niccolò Machiavelli e della sua opera principale Il Principe, che ha reso “machiavellico” un termine ormai perfettamente comprensibile e accettato nella lingua corrente.
Ci sono peraltro anche altri autori ai quali è capitato di essere onorati con neologismi modellati sul loro cognome. Ne è un esempio l’aggettivo “kafkiano”, che viene utilizzato per descrivere una situazione caratterizzata da assurdità burocratica e senso di impotenza, che spesso sfocia in situazioni surreali gestite da forze incomprensibili.
C’è poi il tris un po’ osé degli aggettivi “saffico”, “sadico”, “masochista”, nei quali la fama dei rispettivi scrittori fa immediatamente comprendere a quali elementi caratterizzanti della loro vita e delle loro opere ci si riferisce.
Ma esiste un’antonomasia con cui la lingua corrente può risultare persino più lusinghiera ed è quando a entrare nell’uso comune non è un neologismo riferito direttamente all’autore, ma a uno dei suoi personaggi. Ecco alcuni esempi:
– donchisciottismo (dal Don Chisciotte di Cervantes, riferito a un atteggiamento idealista ma poco realistico, che porta a combattere cause perse o a vivere in un mondo di illusioni)
– bovarismo (da Madame Bovary di Flaubert, utilizzato per descrivere uno stato di insoddisfazione per la propria vita, che fa sognare un’esistenza più affascinante, ma irrealizzabile)
– oblomovismo (dal romanzo di Gončarov, per indicare l’inerzia, l’apatia e la riluttanza ad agire)
– panglossismo (dal Candide di Voltaire, per deridere la tendenza a un ottimismo ingiustificato e ingenuo e a credere che tutto ciò che accade sia per il meglio)
– mefistofelico (dal personaggio diabolico che appare nel Faust di Goethe).
La lista potrebbe continuare, ma preferisco lasciare ai lettori l’opportunità di segnalare qualche ulteriore esempio di come la lingua sappia incessantemente creare nuovi vocaboli che mantengono vivo e fanno circolare il fascino di autori indimenticabili e dei loro più celebri personaggi.
Massimo Pentalogo