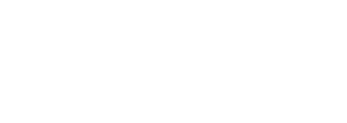APOCRIFA – Mare nostrum e mare eorum

Il Mediterraneo (significato: nel mezzo delle terre) fu prima, con la Repubblica contro Cartagine, sbrigativamente qualificato nostro dagli antichi romani alludendo al Tirreno e poi, con il principato, anche mare interno allo scopo di distinguerlo dall’Oceano, al di là dalle Colonne d’Ercole, oggi Stretto di Gibilterra.
Il sobrio possessivo ritornò in auge con il fascismo e la sua propaganda a partire dalla politica espansiva coloniale, in toni non dissimili da quelli nazisti inneggianti allo spazio vitale (Lebensraum), e indicò obiettivi politici di talassocrazia sul Mediterraneo a rimembranza e ricostruzione della potenza imperiale romana: mare nostrum, quindi e di nuovo, che la regia marina avrebbe protetto e controllato.
Nonostante l’incomodo costituito dalla isoletta di pescator Albione, falsa Inghilterra la quale nel 1940, oltre a controllare Stretto di Gibilterra e Canale di Suez, aveva talune basi navali a Malta, Cipro e Alessandria d’Egitto.
Oggidì, svaniti dal 1944 gli imperialistici bollori e passato più modestamente l’inequivoco titolo a pacifica missione aereo-navale (ottobre 2013-ottobre 2014, poi sostituita dall’Operazione Triton) di salvataggio in mare di migranti che galleggiavano (non sempre) su imbarcazioni di fortuna nel Canale di Sicilia dalle coste africane e maltesi, la originaria sua ratio non è tuttavia andata persa (nulla si crea, nulla si distrugge anche in politica), ma è trasmigrata oltre Atlantico ed è in ancoraggio nel Golfo del Messico.
Golfo recentemente ri-nominato motu proprio Golfo d’America e non indicante l’insieme continentale americano, ma, ambiguamente implicito, soltanto gli USA.
Denominazione subito accettata da Google Maps, ma non da terzi pur con qualche rilevanza come la United Nations Group of Experts on Geographical Names, la Unione Geografica Internazionale, la Organizzazione Idrografica Internazionale (IHO/OHI, precedentemente dal 1921 al 1967 nota come Ufficio Idrografico Internazionale), la Enciclopedia Britannica etc.
Moderne Cartagine sono Venezuela e Colombia, due Paesi che parallelamente si affacciano sulla costa nordica del continente sud-americano e si trovano ad avere davanti a sé, oltre il Mare dei Caraibi (al presente ancora tale), più o meno varcata la linea ideale fra Città del Messico e L’Avana, il sopra menzionato vasto Golfo d’America, novello mare nostrum o, se visto da terzi, mare eorum.
Dal Venezuela le rotte marine dei narcotrafficanti vanno per mare in Florida e in Messico come, del pari, dalla Colombia in Messico e da qui negli USA per cui è oggettivo il flusso unidirezionale da sud verso nord così come è oggettiva la incessante domanda nordica per il consumo degli psicotropi.
Gli USA, schierate navi da guerra e anche un sottomarino nelle acque caraibiche, hanno iniziato a operare in mare aperto internazionale contro imbarcazioni sospettate di narcotraffico affondandole con le armi e provocando morti oltre a conseguenti prevedibili escalation di reciproche tensioni politiche.
Che invero sembrano però essere quasi l’obiettivo principale delle azioni militari dato che il pretesto, così qualificato e contestato dalle controparti le quali negano l’illecito, potrebbe essere abbastanza facilmente verificato fermando il naviglio sospetto (se le informazioni dell’intelligence sono veritiere) e sequestrandone pubblicamente il carico: l’evidente (e sbilanciato a favore USA) potere d’intervento a colpo sicuro su navigli civili, anche se -nel caso- malavitosi, consentirebbe di interrompere nel vivo il traffico nefasto e al contempo evitare polemiche inutili poiché alla luce del sole.
E’ pur vero che nelle relazioni politiche una delle regole preferite nella rissa è la negazione dell’evidenza, ma va da sé che ove il soggetto il quale difenda i propri legittimi interessi possa (oltretutto e per lo strapotere che ha sopra l’antagonista come in questi casi) permettersi di rispettare (unilateralmente e di propria scelta) anche il buon senso e un minimo di onestà intellettuale, peraltro senza neanche assumere rischi, si porrebbe in prospettiva etica e giuridica ben differente rispetto ai contendenti e alla platea in genere degli osservatori.
Ambedue i presidenti sudamericani, che nei fatti hanno più di una coda di paglia non potendo negare il narcotraffico prodotto dai propri cittadini, protestano infatti vivamente contestando che siano uccisi innocenti e poveri civili.
L’ultimo incidente (ora c’è anche una portaerei a 24 miglia dalle coste del Venezuela per esercitazioni navali con Trinidad e Tobago) tra Washington e Bogotá, con il presidente qualificato leader della droga illegale e conseguente richiamo in patria dell’ambasciatore colombiano, è considerato da taluni osservatori e analisti segnale inquietante anche per altri Paesi della America del Sud -a eccezione dell’Argentina con (allo stato) rapporti stabili e subordinati con gli Stati Uniti- i quali osservano con crescente preoccupazione la politica americana del mare nostrum e temono possibili pressioni commerciali (consuete manovre su dazi etc) e ingerenze dirette o indirette.
E a proposito delle (talora) significative diversità che si riscontrano, a livello internazionale, nei reciproci rapporti di forza o debolezza fra Paesi, torna alla memoria la vicenda della Enrica Lexie, la petroliera italiana sulla quale erano imbarcati alcuni fucilieri di marina a protezione contro aggressioni in mare che sfociò in dura controversia infinita a motivo della uccisione di due pescatori indiani operanti su di un naviglio commerciale scambiato per pirata. La diatriba giudiziario-politica, iniziata nel 2012 con l’arresto da parte della polizia indiana di due militari italiani, si chiuse dieci anni dopo e un risarcimento di 142.000 euro da parte del governo italiano a ciascuna famiglia.
Mare nostrum e mare eorum: il parametro di riferimento è pur sempre quello a tutti ben noto (e universalmente applicato) del titolo quinto.
LMPD