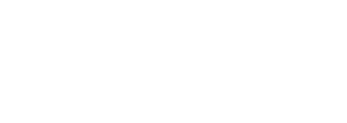APOCRIFA – Rito ambrosiano (2)
Nondimeno le parole di un episcopo, dalla medesima cattedra di quel tardo trecentesco Ambrogio che in tempi calamitosi si ebbe una investitura popolare irresistibile alla quale, dopo avere cercato, novello Giona, con ogni forza di sfuggire, corrispose in modo tanto completo da connotare una forma liturgica ancora oggi autonoma nella latinità, sono uno spunto per la società civile e per le sue istituzioni onde convergere, o comunque provare a farlo, in sincerità di coscienza e di intenzione verso interventi di correzione e di miglioramento effettivo di un sistema malato.
Le parole in cui l’uomo odierno si annega (o è annegato) quotidianamente sono così tante e troppe da avere perso ogni significato fino a diventare insignificante o incomprensibile rumore quindi è bene che, ove esse abbiano -come in questo caso- viceversa senso e valore ci si provi a scriverle: messaggio da rilasciare nella bottiglia preda della corrente e così è avvenuto: un libretto di trenta pagine con la copertina verde che si legge in pochi minuti.
E che si può anche rileggere uscendo dalla logica vacua delle parole (meglio: rumori) che a sera sono già appassite.
Ma è istruttivo vedere e ascoltare anche dal vero, per il tramite della registrazione disponibile sul sito, perché la postura dell’oratore contribuisce a dare alle sue parole un valore particolare.
Per un milanese, ancorché acquisito, il riferimento spontaneo (naturaliter automatico) all’episcopo erede di Ambrogio è forse più facilmente C. M. Martini: ieratico, didascalico, autorevole, assertivo, presente anche fra i non credenti: ventidue anni di cattedra come Aurelio Ambrogio da Treviri.
Sembrava, in tante occasioni, avere egli appena riposto sullo scrittoio un rotolo della Torah o un papiro evangelico e poteva richiamare all’immaginazione Isaia, profeta di stirpe sacerdotale.
M. E. Delpini, il 6 dicembre scorso, impersonava viceversa uno di quei più anonimi, ma del pari evangelicamente fondamentali e potenti, discepoli mandati in missione che stanco del viaggio varca una soglia e dice Pace a questa casa e dopo averlo detto è pronto sia con semplicità a rimanere sia, con uguale semplicità, a scrollarsi la polvere dai sandali sul limitare e ad andarsene: fa quello che il Maestro gli ha indicato di fare e, avendolo fatto, il problema della pace non è più soltanto suo.
Sotto il profilo formale-estetico, ma è un parere personale, sarebbe stato ancora più appropriato se vestito di una tunica di duemila anni or sono o di un semplice saio giacché le elaborate insegne ecclesiastiche non si addicono del tutto né a lui (come peraltro ad altri presbiteri) né a quello che dice: la sua voce non concede nulla alla cattedra, che pur c’è, ed è monocorde come di chi puntualmente compie un dovere che è anche servizio non privo di pena grande perché oggetto di possibile (e continuo) rifiuto come già avvenuto al Maestro: e sai quanta polvere deve avere già scosso dai calzari verso i molti che lo hanno guardato e sentito compunti senza ascoltarlo.
Solo i suoi occhi non smettono, anche leggendo fogli un po’ gualciti e, s’immagina, in ordine a fatica, di guardare negli occhi coloro che gli stanno di fronte.
Uno sguardo difficile da cui districarsi.
Perché è nel raggiungere in modo diretto, e senza diaframmi, la mente di coloro che possono, in qualche modo, essere responsabili di qualcosa, nel bene e nel male, che le parole fanno sempre arco voltaico con qualsivoglia tipo di realtà e in particolare se, come nel caso di specie, realtà drammaticamente critica, deteriorata, usurata dalla ripetizione colpevole, con o senza nome, fino al nascondimento della speranza.
Curare il male e il duolo della terra è un’impresa non facile neanche per Dio, come ben emerge dalla missione di Gesù di Nazaret, e in ogni caso non è mai opera o funzione collettiva (una Assemblea, un Senato o, a maggior ragione, uno Stato), ma scelta personale di singoli i quali, per qualsivoglia motivo, agiscono di persona e per il tramite del loro agire coinvolgono anche e di conseguenza, in misura variabile e talora fino al non coinvolgerlo per nulla, il collettivo.
Da quel poco che l’essere umano, credente o in ricerca, riesce a intuire circa la vita e il destino, il nodo gordiano del mistero dell’uomo presenta una natura duplice e interconnessa: da un alto la libertà, patrimonio o talento di rango divino e condizione perché possa essere azzardata, qualunque cosa significhino nella realtà, i due ben noti termini ‘immagine e somiglianza’ con Dio e, dall’altro, la sempre attiva e ineludibile presenza fisica e metafisica di un principio contrario verso il quale ben può l’uomo, in virtù della sua libertà, indirizzare a danno suo proprio e del prossimo scelte e comportamenti.
Così, solo per accenno, dal Deuteronomio Vedi, io metto oggi davanti a te la vita e il bene, la morte e il male (Dt 30,15) all’ancora più esplicito Prologo di Giovanni in cui la luce splende nella tenebra e la tenebra non la accolse o, come si traduce oggidì il verbo greco di non univoco significato, la tenebra non la vinse (sopraffece).
E subito poi è sottolineato che a quanti però lo accolsero diede il potere di diventare figli di Dio.
Una scelta, quindi: e sempre singola e personale.
E uno che se ne intendeva, come C. M. Martini, ebbe ai primi degli anni ’90, in tèma di etica, a spezzare un lancia circa l’opportunità di adottare un atteggiamento maggiormente ottimistico pur riconoscendo l’inutilità di sperare in una società perfetta, che è il motivo per cui le rivoluzioni falliscono nella tragedia: basterebbe infatti aspirare a una società più giusta e più buona da costruire non certo con la cura di anonimi ‘altri’ di là da venire, ma con i sacrifici, hic et nunc, degli onesti (Dipende dalla mia, dalla vostra buona volontà e chi ha fede, fosse pure solo nel mistero dell’uomo, avverte che questa è l’unica strada possibile […]).
Non diverso, invero, da quanto scandito da monsignor Delpini alla città il 6 dicembre scorso (e, senza andare tanto lontano, da quanto esortava il Maestro all’inizio della sua vita pubblica: Cambiate modo di pensare, convertitevi).
Naturalmente rimangono sullo scenario coloro che, e sono maggioranza, non hanno fede in nulla se non nell’importanza delle cariche e nella certezza materiale dei loro letti d’avorio e che della rovina altrui non si preoccupano: lì per lì ciascuno si crede più furbo di chi lo ha preceduto e dell’esperienza, vista a posteriori, rifiutano ogni contezza.
Ma non sembrano in ogni caso essere in grado di sottrarsi, per loro (e non solo loro) disgrazia, a quanto scriveva a proposito un profeta minore del secolo VIII a. C.: … cesserà l’orgia dei dissoluti/buontemponi (Amos 6,7).
E non solo in Samaria per la casa d’Israele, come in realtà puntualmente accaduto nella storia, ma per ciascuno e per tutti poiché le situazioni, ieri oggi e domani, sono poi sempre le stesse dato che nemmeno il male, per quanto ci si ingegni, mai cambia né natura né modalità (in particolare ingiustizia sociale e degenerazione del potere).
LMPD
(la prima parte dell’articolo è stata pubblicata sul precedente n. 231)