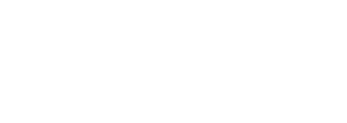APOCRIFA – Sul ciglio della pace
Scivolare è pericolo dato che, in particolare, non è detto si riesca sempre a rialzarsi come dimostrano, nei secoli, le vicende di civilizzazioni scomparse senza lasciare traccia oppure assorbite e fagocitate da altre.
A fronte di un attuale scenario connotato da delirio d’onnipotenza coltivato da (pochi, ma sufficienti) tiranni affetti in varia misura sia dalla sindrome di Attila o Gengis Khan sia dal complesso dell’inviato di dio si leva una interlocuzione fra chi sostiene le ragioni della pace giusta e chi, al contrario, preferisce (o è disposto ad accettare) la pace ingiusta pur di giungere a un’intesa qualsiasi in grado (si suppone) di fare cessare ostilità e pericoli.
Ambo le parti presentano talune contaminazioni, chiamiamole così, di ordine ideologico e in tal modo le prime di matrice etico-utopica e le seconde di matrice contingente oltre che moralmente empiriche o relativistiche.
Inoltre da un lato i soggetti sono in realtà noti o identificabili, mentre dall’altro i soggetti costituiscono un insieme estemporaneo e strumentale, considerando che alla rinfusa vi partecipano in gran numero anche sovranisti, populisti e quinte colonne a favore dei tiranni.
Giusta è (sarebbe) la pace in grado di terminare un conflitto armato -che difficilmente è giusto se non dal lato di chi si è legittimamente difeso essendo stato assalito- ristabilendo l’uso del diritto internazionale, per quanto esile esso sia, e ponendo presupposti reali per una possibile oltre che probabile convivenza dei governi dei popoli in prospettiva anche di una rinnovata promozione e fiducia negli strumenti e organizzazioni sovra-nazionali. Essa comporta un ripensamento da parte di tutti, ovviamente, ma in particolare una qualche forma di resipiscenza, non necessariamente ammessa come tale, da parte di chi ha dato luogo al conflitto.
Difficile invero appare un processo siffatto se il soggetto agente che ha causato il conflitto rimane il medesimo, salvo una sua quantomeno parziale conversione nel senso letterale del termine.
Ingiusta è la pace -o meglio l’interruzione o meglio ancora la sospensione del conflitto in armi- negli altri restanti casi di cui la storia, sebbene scritta dai vincitori, è cortese di innumeri esempi vicini e lontani: nella ingiustizia, vale a dire nella esagerazione e iniquità delle clausole contrattuali imposte, è il seme tenace e ben germinante di prossimi nuovi conflitti.
Dato e non concesso, si capisce, che la parte perdente rimanga tale e non si dissolva sotto il giogo della parte che ha vinto.
Ulteriore, ma non marginale, considerazione è (sarebbe) che la pace, per essere tale, potesse venire negoziata fra parti non del tutto squilibrate tanto da trasformarsi in patto leonino, prospettiva cioè non di incontro, per quanto duro e difficile, ma di coartazione: concetto comune a tutte le culture giuridiche di un minimo di serietà.
Onde appare evidente che in assenza di credenziali e condizioni sufficienti, cioè di attendibile capacità di auto-difesa, una trattativa di pace altro non è che finzione, a senso unico, destinata a rivelarsi e a risolversi in quello che essa è, menzogna e tragica farsa.
Hanno quindi ragione Francesco papa e il presidente della italica Repubblica a levare alta e chiara, senza inutili giri di parole, voci di avvertimento nonostante la rispettiva debolezza.
Quante divisioni ha il papa? E l’Italia?
Se autorevolezza e assertività morale e spirituale (ideologia di matrice etica-utopica) abbiano o non abbiano ancora futuro e quale futuro lo diranno, e certo a breve, i prossimi eventi.
Così come, dall’altra parte, potrebbe anche riservare qualche sorpresa il dinamismo, al di fuori e anzi ostico verso i più tradizionali mezzi diplomatici, dei due maggiori imperialisti attuali i cui approcci internazionali (oltre che nazionali) assomigliano più a quelli di capi tribù piuttosto che a quelli di uomini di stato.
E, come tali, rapidi a trovarsi (anche paradossalmente) d’accordo in nome di rispettive, pur se contingenti, convenienze e dell’eterno non olet, ma altrettanto rapidi a ri-dividersi e a morsicarsi.
D’altra parte, senza andare tanto lontano, è appena del 1939 il patto Molotov-Ribbentrop e sono del 1939, 1940 e 1941 gli accordi commerciali fra i dittatori tedesco e sovietico validi, a onta degli impegni scritti, unicamente fino al giugno 1941 quando, secondo il costume delle bande, uno dei due saltò a tradimento addosso all’altro (Operazione Barbarossa).
Il conflitto fra etico-utopia (diritto) e amorale-empirico relativismo (forza) non è peraltro una novità, ma trova acuta interpretazione fin da uno storico greco del V secolo a. C., l’ateniese Tucidide che fu anche navarca o stratega navale (perdente) contro Sparta nella lunga guerra del Peloponneso da lui narrata in un capolavoro storiografico e quindi a lungo fuoriuscito o esule presso gli alto-criniti semibarbari Traci.
La sua concezione storico-politica, moderna e intramontabile, è razionale e fondata sulla considerazione che così come la natura umana è insaziabilmente portata ad accrescere il proprio potere, in modo analogo agisce anche la società politica cui non resiste altro limite se non forza uguale e contraria.
Nel caso concreto di quei tempi, le città principali Atene e Sparta accrebbero la rispettiva potenza sottomettendo le città più deboli e quindi entrarono in un conflitto cui né accordi né trattati né alleanze poterono, se non per brevi pause, portare rimedio: fino all’annientamento della rivale (in realtà rovina reciproca).
Onde il principio è che la politica agisce tramite rapporti di forza e la guerra è il suo mezzo operativo d’elezione unitamente al (copioso) denaro necessario per sostenere e alimentare la guerra medesima: analisi spietata e arida da cui emerge un profilo di storia brutale governata da uomini assetati di potere e di risorse materiali fino ad esserne tossicamente dipendenti, ove considerazioni di ordine etico non trovano spazio.
Nella guerra del Peloponneso (come peraltro in una quantità inverosimile di analoghe vicende belliche di ogni tempo fino a oggi) si mostra applicata la regola di Tucidide e nella specie anche il conseguente, lungo e irreversibile tramonto di Atene la cui un tempo gloriosa lega marittima si era trasformata da civile baluardo verso l’espansione orientale in imperialismo oppressivo né condusse a migliori destini Sparta, la faticosa vincitrice, ma segnò l’inizio del piano inclinato e la fine per la Grecia tutta.
La sintesi del pensiero dello storico si trova nel V (85-114) libro applicata a una vicenda non di primo piano: il colloquio fra gli ambasciatori ateniesi e i Melii, sfortunati abitanti di un’isola neutrale anche se nell’area di influenza spartana, che non vollero entrare a fare parte della lega ateniese di cui, per verosimiglianza attuale (sembrano infatti scritti oggi per oggi), seguono alcuni estratti.
(89.) Ateniesi: Da parte nostra, non faremo ricorso a frasi sonanti; non diremo fino alla noia che è giusta la nostra posizione di predominio perché abbiamo debellato i Persiani […] Bisogna che da una parte e dall’altra si faccia risolutamente ciò che è nella possibilità di ciascuno e che risulta da un’esatta valutazione della realtà. Poiché voi sapete tanto bene quanto noi che, nei ragionamenti umani, si tiene conto della giustizia quando la necessità incombe con pari forze su ambo le parti; in caso diverso, i più forti esercitano il loro potere e i più deboli vi si adattano.
Siamo ora qui, e ve lo dimostreremo, per consolidare il nostro impero e avanzeremo proposte atte a salvare la vostra città, poiché noi vogliamo estendere il nostro dominio su di voi senza correre rischi e nello stesso tempo salvarvi dalla rovina, per l’interesse di entrambe le parti”.
(92.) Melii: E come potremmo avere lo stesso interesse noi a divenire schiavi e voi a essere padroni? […] (94.) Allora non accettereste che noi fossimo, in buona pace, amici anziché nemici, conservando intatta la nostra neutralità?
(95.) Ateniesi: No, perché ci danneggia di più la vostra amicizia, che non l’ostilità aperta: quella, infatti, agli occhi dei nostri sudditi, sarebbe prova manifesta di debolezza, mentre il vostro odio sarebbe testimonianza della nostra potenza. (105.) […] Gli dèi, infatti, secondo il concetto che ne abbiamo, e gli uomini, come chiaramente si vede, tendono sempre, per necessità di natura, a dominare ovunque prevalgano per forze. Questa legge non l’abbiamo istituita noi, non siamo nemmeno stati i primi ad applicarla; così, come l’abbiamo ricevuta e come la lasceremo ai tempi futuri e per sempre, ce ne serviamo, convinti che anche voi, come gli altri, se aveste la nostra potenza, fareste altrettanto.
Non diversamente ragiona uno il quale decide, dopo la Crimea, di prendersi con le armi uno Stato libero e sovrano, che ha il torto di essergli confinante o un altro che dichiara di avere necessità di prendersi la Groenlandia, il Canada, Panama e dopo avere ri-etichettato a modo suo sul mappamondo il Golfo del Messico, provvederà anche, perché no? con i due Oceani, uno a destra e uno a sinistra, che non si capisce in effetti perché debbano chiamarsi Atlantico e Pacifico anziché East e West.
LMPD