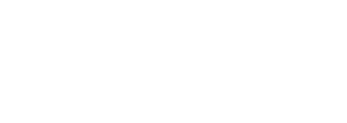DE LITTERIS ET ARTIBUS – Brisa, mica e fragmenta

I dialetti ricordano per certi versi le variazioni musicali, che consistono nella ripetizione di un tema con alcune modifiche, che – pur mantenendo un legame riconoscibile con il tema di base – presentano nuove idee e sviluppi musicali interessanti.
Nei dialetti si verifica – in modo del tutto spontaneo – un procedimento analogo e i risultati sono altrettanto sorprendenti, perché fanno emergere collegamenti suggestivi e nuove sfumature di significato nel linguaggio.
Una bella variazione sul tema, che è presente in due dialetti italiani è il termine bolognese brisa e quello fiorentino mica (pronunciato con una c rigorosamente aspirata).
I due termini hanno un significato simile e vengono utilizzati come avverbi negativi con enfasi rafforzativa, in modo analogo a ciò che si fa nella lingua italiana con per nulla e affatto.
Il tema di partenza di entrambi i termini affonda nell’antica cultura del pane, del quale si mangiavano con rispetto anche le briciole. Da qui i termini bricia (accostata al francese briser, rompere) e mica (che in latino significava briciola e oggi, in alcune regioni italiane, indica la mollica del pane).
Successivamente brisa e mica hanno iniziato ad assumere un significato più ampio, indicando una quantità infinitesimale, qualcosa di estremamente piccolo o insignificante, Da questa accezione, i due termini hanno gradualmente sviluppato un valore di negazione, esprimendo l’idea di neanche un po’.
Se saliamo nelle regioni del Nord Italia, possiamo trovare varianti ulteriori come miga e minga, che hanno avuto discreta fortuna anche in opere letterarie importanti.
Se poi si spicca un salto verso l’empireo della letteratura, troviamo nuovamente un riferimento alla brisa nel Canzoniere petrarchesco, che – non a caso – l’autore aveva originalmente intitolato: Rerum vulgarium fragmenta.
Il fragmentum equivale alla brisa, ovvero è un piccolo o piccolissimo pezzo staccato da qualcosa di più grande.
Secondo alcuni, scegliendo questo titolo, Petrarca ha voluto alludere alla natura frammentaria delle sue poesie scritte in volgare.
Ma c’è chi sostiene che Petrarca abbia piuttosto voluto riconoscere a Dante il primato nell’uso della lingua volgare e affermare con grande umiltà che le sue rime sparse erano solo briciole cadute dal tavolo imbandito dell’autore della Comedia.
Al riguardo, mi piacerebbe conoscere l’opinione dei lettori!
Massimo Pentalogo