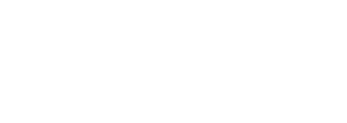L’EDITORIALE – Pace e guerra, ieri come oggi: tra latinorum, retorica e realtà
In occasione del recente intervento al Senato sull’aumento delle spese militari (c.d. riarmo europeo: dal 2% al 5% del PIL), le due prime donne della politica italiana si sono affrontate in punta di fioretto cimentandosi in un dialogo scivoloso intorno alla guerra e alla pace.
Nulla di strano (anzi) che sostenessero tesi opposte, ma riferimenti o prospettive storiche non sempre aiutano a esprimere il pensiero o a fornire valore alle argomentazioni.
A parte, per ora, la singolarità della locuzione non devono essere sacrificati (agli ingenti incrementi militari, ndr) settori chiave come sanità, scuola, welfare e lavoro sulla quale tutti variamente pontificano, ma senza spiegare come ci si riesca o da dove si recuperino le necessarie risorse -forse un altro PNRR pluriennale a fondo perduto- la signora Meloni ha citato un antico detto latino (Si vis pacem, para bellum: se vuoi la pace, prepara la guerra) e la signora Schlein risposto che rispetto a 2000 anni fa il mondo ha fatto dei passi avanti nella risoluzione delle controversie.
Nessuna delle due, nella realtà, ha portato gran che acqua al mulino della propria tesi: viceversa ne ha sottolineato la rispettiva debolezza e due debolezze insieme fanno un discorso unicamente di retroguardia come di coda è in genere, sfortunatamente, il Paese nel nome del quale ritengono di parlare.
La prima declaratoria risale a un’opera del V secolo d. C. di Publio Flavio Vegezio che fu scriba e funzionario statale, non militare, e autore teorico [Chi sa fare, fa; chi non sa fare, insegna] di una opera, L’arte della guerra (Epitoma rei militaris) il cui scopo era la riforma dell’oramai da tempo bolso esercito romano onde riportarlo agli antichi fasti. Le materie erano selezione e addestramento delle reclute, organizzazione della legione, tattica e strategia, attacco e difesa per terra e per mare.
L’opera pare dedicata a Teodosio II, imperatore d’Oriente, sempre alle prese con i Persiani (Sasanidi) e i barbari (Unni e Vandali) oltre agli inevitabili e singhiozzanti equilibri con l’Impero romano d’Occidente.
A parte l’esercizio retorico di Vegezio, il Si vis pacem, para bellum è, nei fatti, un latinorum ipocrita quanto basta, trito e ritrito e in lingua antica (ignota ai più) di per sé intesa a suggerire maggior autorevolezza e usato, in particolare, quando davanti a fronte di ostacoli si vogliono giustificare nuove spese militari e nuovi armamenti.
Inoltre, se preso alla lettera, delinea una pericolosa strategia di progressiva e reciproca rincorsa agli armamenti destinata a terminare quando qualcuno faccia, per scelta o dabbenaggine, cadere l’uovo e scoppiare di nuovo una guerra.
Esempio raro di (efficace) funzionamento del latinorum in parola è stata la Guerra Fredda gestita da due soggetti che pur detestandosi conoscevano ambedue le possibili risultanze di eventuali scivolate (letali per l’avversario e al contempo per sé): allo stato i due originari soggetti appaiono imbolsiti dalle rispettive retoriche e a loro, per di più, si sono aggiunti diversi aspiranti catastrofali.
La seconda declaratoria, invocante i progressi nella risoluzione delle controversie realizzati negli ultimi 2000 anni, al di là delle parole che vorrebbero essere a effetto con il richiamo indiretto al cristianesimo, non considera nemmeno di sfuggita quello che è, viceversa, realmente successo nei menzionati 20 secoli.
Il primo tentativo di ambire a un orientamento di pace sul piano sovranazionale è filosofico e a opera di Kant il quale, con consueta teutonica certezza già nel titolo (Per la pace perpetua) e senza riflettere che si sarebbe potuto intendere anche il camposanto, prospettò una ipotesi di ordinamento giuridico a tutela della pace mondiale.
Seguirono le Convenzioni dell’Aia del 1899 e del 1907, trattati internazionali fra Stati che, di fatto, dominavano la maggior parte del mondo e che furono stipulati in occasione delle due rispettive Conferenze internazionali per la pace. Vennero messe a punto, a proposito di pace, le linee guida per la definizione del diritto bellico (!) e fu costituita la Corte permanente di arbitrato, collocata nel Palazzo della Pace all’Aja, con oltre 120 Stati aderenti e tuttora in funzione sebbene non proprio efficacemente utilizzata.
La Società delle Nazioni originò nell’ambito di tardive resipiscenze, presto tramontate, subito a valle della Conferenza di pace di Parigi del 1919 e fu mestamente chiusa nel 1946, dopo la seconda guerra mondiale, sostituita (così sembrò meglio) da altra organizzazione con uguali finalità, le Nazioni Unite, cui aderirono anche gli USA, assenti nella precedente organizzazione.
I principi aurei ispiratori peraltro sempre i medesimi, così come medesimi sono pensieri e comportamenti (e qui è il fallo) degli individui che, pur fisicamente diversi, si avvicendano nelle istituzioni.
Ma sfortunatamente non esiste niente e non c’è nessuno che possano garantire l’applicazione alla realtà di principi formali (analogamente, se non esistessero forze dell’ordine e tribunali, nelle civilissime città moderne la vita sarebbe aleatoria come quella delle caverne) onde i progressi nella risoluzione delle controversie sono rimasti tali e quali analoghi a quando il Signore Gesù, giusto 2000 anni or sono, esortava, peraltro non mai ascoltato, alla coscienza e alla pace reciproca.
Ma tornando al latinorum, è forse interessante dare uno sguardo, più che alla formula in sé, alle organizzazioni socio-politiche dei tempi andati e alle azioni conseguenti in secoli più vitali rispetto a quelli pre-agonici dei due Imperi Romani in inesorabile disfacimento.
E gli antichi, Greci e Romani, erano imperialisti e (modernamente parlando) guerrafondai.
Tucidide analizza (modernamente, peraltro) gli eventi storici secondo il metro della sola natura umana e, al pari di medico a fronte di morbo crudele, individua nella natura umana la brama insaziabile di accrescere la potenza onde non le si dà limite se non esplicato da forza uguale e contraria.
La devastante e lunga guerra del Peloponneso è il drammatico laboratorio della ricerca storiografica da cui emerge la direzione verso la reciproca distruzione di Atene e Sparta, indotta dalla contrastante pura volontà di sopraffazione cui non soccorrono né intelligenza né virtù né trattati né alleanze né armamenti né deterrenze.
La logica bruta del rapporto internazionale è sintetizzata nell’interlocuzione famosa fra gli ambasciatori ateniesi e gli abitanti dell’isola di Melo, peraltro neutrali, ma inermi davanti al prepotente di turno e destinati alla fine.
Nell’Urbe, Catone il Vecchio, severo e fedele servitore della Repubblica oltre che campione indiscusso delle più incontaminate romane virtù cui la posterità invano agognò (a parole) di ritornare, colui che fece le pulci per dissipazione di pubblico denaro all’eroe del momento, Scipione l’Africano, concludeva ogni suo intervento pubblico con l’esortazione a distruggere Cartagine (Ceterum censeo Carthaginem delendam esse: ‘Per il resto ritengo che Cartagine debba essere distrutta’).
A Cartagine, ovviamente, non diversamente dicevano circa Roma.
E l’ottimo Cicerone, avversando fieramente Marco Antonio all’indomani della morte di Giulio Cesare per mano di liberatori tirannicidi che la ribollente plebe capitolina non riconosceva però come tali, nelle Filippiche, un po’ il suo testamento politico, inverte l’ordine degli addendi (… se vogliamo godere della pace, bisogna fare la guerra; se rinunciamo alla guerra, non godremo mai della pace …), ma il risultato non cambia e la vecchia Repubblica già azzoppata dalla lunga guerra civile naufraga miseramente e per sempre nella tirannide.
Inoltre Tacito, tra l’altro non contrario di per sé all’espansione della civilizzazione romana (lui originario della Gallia), ma al comportamento abbietto degli Imperatori dei quali descrive l’ipocrita imperium (depredare, trucidare, rubare), scolpisce una volta per tutte e per tutti, -compresi i tiranni di oggi- la logica sempre uguale dei (tanti) predatori del mondo: e dove fanno il deserto, lo chiamano pace.
Non è cambiato sostanzialmente niente, solo il nome dei despoti di turno.