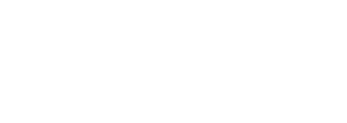L’APPROFONDIMENTO – Parola di Dio (II)
I numerosi manoscritti rinvenuti, andati persi gli originali, non sono in lingua semitica, ma per lo più in greco e quindi rilevante importanza riveste, per gli studiosi, la questione della loro più attendibile datazione: in particolare motivando molti di essi la necessità che trascorra tempo sufficiente al radicarsi delle narrazioni (e per taluni anche le leggende) nella cultura (sostanzialmente orale) dei tempi e dei luoghi.
In tale orientamento buona parte degli esegeti hanno concordato, in assenza di riferimenti storici, per una datazione tendenzialmente bassa, vale a dire più lontana dalle parole del rabbi e dagli eventi di riferimento.
E hanno quindi accolto criticamente, in quanto capace di mettere in dubbio e vulnerare tale tradizionale ricostruzione, il lavoro di J. Carmignac che, esperto in lingue semitiche, ebbe un giorno l’intuito di tradurre il testo di Marco dal greco antico, in cui esso è noto, all’aramaico parlato al tempo di Gesù scoprendolo del tutto conforme alla mentalità e prosa semitica: in tale modo pervenendo alla motivata e verosimile idea trattarsi, il testo di Marco, di traduzione in greco di precedente originario testo semitico.
Questa tesi rovescia la prospettiva tradizionale e, in particolare, sposta decisamente in alto la redazione dei primi scritti evangelici avvicinandoli significativamente a detti ed eventi e, in sostanza, storicizzandoli.
Vale a dire riconoscendo validità storica a testimonianze avvenute a ridosso dei fatti e quindi sottraendole all’ipotesi della sedimentazione culturale-leggendaria.
In pratica il c.d. Vangelo dei detti Q (o discorsi o Fonte Q) potrebbe collocarsi verso il 42-45 e forse anche prima, il testo semitico di Marco (l’originale potendo anche essere dello stesso Pietro, ma ricordato con il nome di chi poi lo tradusse in greco) verso il 42 e Marco greco (traduzione, a Roma, del testo di Pietro) non oltre il 63 (anziché il 70). Matteo semitico fra il 33 e il 42 (la sua traduzione in greco una decina d’anni più tardi) e Luca greco (con uso di documenti semitici precedenti) poco dopo il 50 o 58-60 (anziché entrambi, Matteo e Luca, al 70-90). Gli Atti intorno al 61-63 anziché 80-90.
Attenzione per una anticipata data merita anche il testo di Giovanni, tradizionalmente collocato al termine del I secolo, posto che è ben attendibile come Giovanni, quantomeno in un suo nucleo originario e anch’esso forse in aramaico, non sia posteriore al 70 d. C. poiché, in accesa come è polemica con i Giudei che rifiutano Gesù, non avrebbe mancato di registrare la distruzione del tempio per mano dei Romani.
Quindi è chiamata parola di Dio il risultato dell’opera collettiva di tutti questi operai senza nome (solo di Saulo Paolo si conosce qualcosa di certo) che, nel corso del primo tempo, hanno lavorato nella medesima vigna e ascoltato, ognuno a modo proprio, il soffio del medesimo Spirito e allora amato, pensato e scritto del medesimo (inafferrabile oltre che ineffabile e misterioso) uomo poi ben presto riconosciuto (anche) come Dio.
La scrittura evangelica è opera materiale dell’uomo e parola di Dio in quanto -da credenti- se ne riconosca proprio il suo sostanziale anonimato terreno e quindi il largo spazio necessariamente lasciato allo Spirito il quale opera in esso e per esso (ispirazione divina: in difetto la scrittura non sarebbe né vera né sacra, ma opera letteraria, filosofica o teologica sebbene spiritualmente elevata come peraltro diversi nobili scritti dell’antichità).
Rimane quindi parola di Dio nonostante sia stata prodotta non da qualche (forse più tranquillizzante e in ogni caso più certa, come in altre credenze religiose) forma di dettatura divina, ma dalla libertà di uomini attratti dallo Spirito (ispirati: poiché Dio non altera né aliena l’umanità dei suoi collaboratori) ancorché ciascuno con le proprie caratteristiche, pregi e limiti.
Non è allora fuori luogo rammentare, forse, come già Pascal abbia osservato che C’è molta differenza fra un libro scritto da un individuo e lanciato in mezzo a un popolo, e un libro che viene fatto dal popolo stesso.
Francesca Penazzi
(Continua. La prima parte dell’articolo è stata pubblicata sul precedente numero 241)