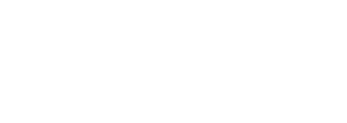L’APPROFONDIMENTO – Parola di Dio (III)
E ‘parola di Dio’ è altresì considerato il complesso di rotoli noto come Antico Testamento che comprende una vastità di scritti molto diversi per generi letterari (narrativo, poetico, storiografico, profetico, sapienziale, legislativo, apocalittico, imprecativo, salterio), origine, datazioni, stili, attribuzioni etc composti nel corso di alcuni secoli dopo una tradizione orale ben più antica e maggiormente difficile, in quanto più lunga e più addietro nel tempo, da delineare rispetto a quella del NT.
La parola Bibbia, termine risalente al XVI secolo e curiosamente al singolare per comprendere un siffatto vasto insieme di scritture, deriva dal latino volgare biblia formatosi sul più preciso greco tà biblìa (i rotoli) e per i cristiani comprende anche il Nuovo Testamento (Vangeli, Lettere e Apocalisse), mentre per gli ebrei è Tanakh, acronimo delle (tre parti) Torah, Nevi’im e Ketuvim:
Torah (Legge o Istruzione-Insegnamento, in greco Pentateuco: 5 rotoli: Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio);
Nevi’im (Profeti anteriori o Libri storici: 6 rotoli: Giosuè, Giudici, Samuele I e II, Re I e II. Profeti posteriori o Libri profetici: 15 rotoli: Isaia, Geremia, Ezechiele, Osea, Gioele, Amos, Abdia, Giona, Michea, Naum, Abacuc, Sofonia, Aggeo, Zaccaria, Malachia);
Ketuvim (Agiografi o Scritti sacri: 13 rotoli: Salmi, Proverbi, Giobbe, Cantico dei cantici, Rut, Libro delle lamentazioni, Qohelet, Ester, Daniele, Esdra, Neemia, Cronache I e II).
Per gli ebrei la Torah comprende tutti i precetti e gli insegnamenti, sia scritti sia orali, rivelati direttamente da Dio a Mosè sul Sinai e al tabernacolo (il luogo della presenza di Dio durante la vita nel deserto) e quindi raccolti e scritti dallo stesso Mosè (salvo le ultime righe del Deuteronomio che narrano la morte del profeta) per il popolo.
Per i rabbini sono Torah sia quella che è scritta (i primi cinque rotoli, per noi Pentateuco) sia quella è detta (codificata progressivamente per iscritto principalmente nel Talmud e Midrash e comprendente interpretazioni e ampliamenti tramandati nel tempo).
È possibile che il significato da attribuire alla locuzione ‘scrittura ispirata da Dio’ sia non proprio equivalente, quanto a ciò che si intende, fra ebrei e cristiani così come anche fra gli stessi cristiani.
La tradizione rabbinica si connota per una analisi accurata condotta con acribìa anche sulla singola parola della scrittura ritenuta definitiva e -a parte l’aspetto non marginale della vocalizzazione che può condurre a risultati diversi pur dalla medesima base consonantica in cui la parola è scritta- il termine ‘ispirazione’ è già di per sé ignoto all’ebraico e all’aramaico che, là dove si traduce ‘ispirazione’ utilizzano forme diverse come: ‘era su di loro’, ‘pose nel mio cuore’, ‘così dice il Signore’ etc.
Il termine ‘ispirazione’ compare in Paolo con theopneustòs (alla lettera soffio-respiro di Dio: poi si collega allo Spirito Santo) e circa il come testi considerati sacri siano stati redatti da uomini ispirati da Dio, esiste varietà di opinione onde si spazia da una visione integralista di dettatura verbale da parte di Dio all’agiografo (una sorta di copista) tipica di movimenti cristiani riformati per i quali il contenuto della Bibbia è solo da Dio, privo di errori e va preso alla lettera (analogamente nella tradizione islamica il Corano è stato dettato a Maometto) ad altre orientate viceversa a trovare equilibrio fra la fonte divina, che è autrice, e la collaborazione umana.
Nel cristianesimo cattolico ci si può riferire, da ultimo, alla costituzione Dei Verbum del Concilio vaticano II (18 novembre 1965), per la quale autore primo e unico della Bibbia è bensì Dio, ma anche gli agiografi sono veri autori:
I libri della sacra Scrittura, […] scritti per ispirazione dello Spirito Santo, hanno Dio per autore […]. Ma per comporre i libri sacri Dio scelse alcuni uomini e si servì di loro nel possesso delle loro facoltà e capacità, affinché, agendo egli in essi e per loro mezzo, scrivessero come veri autori tutte e soltanto quelle cose che egli voleva fossero scritte.
Precedentemente nella enciclica Divino Afflante Spiritu di Pio XII (30 settembre 1943) era stata accolta la visione organica, già presente in epoca patristica, per la quale lo scrittore veniva visto (in analogia peraltro con la moderna teoria della funzione umana nelle persone giuridiche) come strumento nelle mani di Dio, pur lasciandogli la propria personalità con facoltà e conoscenze vale a dire riconoscendogli un ruolo attivo e partecipe di cui necessariamente tenere conto in sede di ricerca e di interpretazione dello scritto biblico:
Partendo nelle loro disquisizioni (i teologi, ndr) dal principio che l’agiografo nello scrivere il libro sacro è organo, ossia strumento dello Spirito Santo, ma strumento vivo e dotato di ragione, rettamente osservano che egli sotto l’azione divina talmente fa uso delle sue proprie facoltà e potenze, che dal libro per sua opera composto tutti possono facilmente raccogliere “l’indole propria di lui e come le sue personali fattezze e il suo carattere” (Cfr. Benedetto XV, Enc. Spiritus Paraclitus). Quindi l’interprete con ogni diligenza non trascurando i nuovi lumi apportati dalle moderne indagini, procuri discernere quale sia stata l’indole del sacro autore, quali le condizioni della sua vita, in qual tempo sia vissuto, quali fonti scritte e orali abbia adoperate, di quali forme del dire si avvalga.
La maggioranza della tradizione cristiana, a parte quindi correnti, non poche invero, fondamentaliste e restaurazioniste che professano il principio della infallibilità delle Scritture (sempre prive di errori in tutto ciò che dicono e da prendere alla lettera) crede la Bibbia ispirata da Dio e infallibile in materia di fede e di morale, ma non necessariamente esente da errori nelle sue parti storiche e scientifiche.
Il Concilio Vaticano II (Dei Verbum, capitolo III) afferma che la Bibbia contiene senza errori la Verità che si riferisce alla nostra salvezza (causa humanae salutis), concezione anticipata già nel XVI secolo dal cardinale Cesare Baronio (Le Scritture spiegano come si vada in cielo e non come va il cielo) e, laicamente, da Galileo Galilei (la Bibbia non spiega come natura agisca, ma insegna agli uomini le verità che sono necessarie per la salute loro: cioè lo scopo è di insegnare fede e morale, non astronomia e altre scienze).
Nello stesso solco fu anche, fra altre sue numerose interpretazioni né invero tutte incontestate, il multiforme e prolifico Origene di Alessandria (II-III secolo d. C.): Sappiamo che la Scrittura non è stata redatta per raccontarci le storie antiche, ma per la nostra istruzione salvifica (Omelie sull’Esodo, 2,1).
Francesca Penazzi
(Continua. Le prime parti dell’articolo sono state pubblicate sui precedenti numeri 241 e 242)