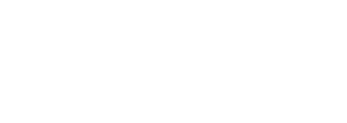L’APPROFONDIMENTO – Parola di Dio (I)
Leggere i Vangeli non è sempre facile dato che la ragione è indotta a confrontarsi con la fede -misura della relazione della singola creatura con Dio come anche della risposta di ciascuno alla chiamata od offerta divina- e i due piani non si aiutano.
Questa sembra essere infatti la prospettiva razionale della creatura davanti al Signore nascosto e al suo silenzioso mistero: l’argomento di fede non si presta (se non marginalmente e in modo frammentario) a essere argomento di ragione e la scienza, quando è consapevole dei suoi limiti, si arresta sul lido di quel mare e delle sue onde infinite, respiro dell’Universo.
Intorno alla inesausta domanda e ricerca circa Dio, è valido ricordare il rischio del metodo scientifico usato a sproposito, rischio simbolizzato dal brillante fisiologo illuminista P. J. G. Cabanis il quale, nell’entusiasmo epocale della fiducia per la scienza che, superate le oscure superstizioni, avrebbe fornito all’uomo tutte le risposte, dopo trent’anni di dissezione di cadaveri si dichiarava convinto, non avendola mai trovata né individuato nel corpo umano il posto dell’anima, che l’anima non esistesse (… cercava, l’anima nel corpo inanimato, privo d’anima per definizione).
Pascal, a esempio, delineata la differenza fra esprit de géométrie (mentalità geometrica) ed esprit de finesse (mentalità intuitiva) scrisse che Niente è così conforme alla ragione come questa rinunzia della ragione a fare qualcosa che sa di non essere in grado di compiere.
In una delle lezioni pubblicate dal Corsera in occasione della maturità, L. Canfora qualifica il Vangelo come libro scandaloso, con ciò sottolineandone fin dal significato etimologico della denominazione (scàndalon: inciampo, ostacolo) la eccezionalità e singolarità dei contenuti.
In esso vi è infatti presentato e insegnato un Dio che nessuna fantasia o speculazione o umana invenzione, per quanto libera e ardita, sarebbe mai giunta a sperare e nemmeno a immaginare: un Dio impensabile e irriconoscibile a filosofi e religioni, un Dio che ama e va verso le creature.
La scrittura enunciante lo scandalo, oltre a non essere storica né sistemica, è piuttosto redazione posteriore (sebbene non di molto) della oralità di Gesù protrettica e pressata sia dall’urgenza dell’annuncio divino sia dalla prospettiva della fine (non necessariamente del mondo, ma pur fine della vita che, per ciascuno, corrisponde alla fine del mondo e ognora imminente: stolto, questa notte l’anima di te viene richiesta e vegliate dunque perché non conoscete in quale giorno il Signore di voi viene) ed è reduce da una gestazione -prima orale e poi scritta- avvenuta nella civiltà e nella cultura di una terra d’Oriente, la plurilingue Palestina, ove oltre al modo di pensare tipico dei semiti, che rifugge dall’astrazione, la lingua parlata presenta caratteristiche che non ne agevolano comprensione (e traduzione) in differenti culture come la greco-latina.
La fase orale è verosimilmente quasi contemporanea o a ridosso degli eventi, come avveniva nelle società senza altri mezzi di comunicazione e in proposito scrive, a esempio, Angelo Casati che i racconti andrebbero ascoltati come forse fu all’inizio, fuori da una tenda, quando fanno convocazione le stelle, intorno a un fuoco; c’è brace e volti come a specchio infiammati.
Un lungo e (all’inizio) quasi impercettibile, ma resistente ordito si è andato annodando in breve attraverso ricordi, testimonianze, sussurri, incontri, colloqui, dubbi, discussioni e contrasti in particolare durante viaggi a piedi sotto il sole di piccoli gruppi e carovane e in mezzo a bivacchi notturni sotto le stelle, le figure avvolte negli scuri mantelli.
Poi, in parallelo, è attendibile la redazione di iniziali appunti scritti allo scopo di fissare in qualche modo la memoria principalmente di parole e detti di Gesù atti quindi a produrre, di lì a breve, quasi canovacci in cui parole e detti saranno poi calati e ambientati anche in azioni ed eventi.
E’ lo stadio dei più antichi documenti, quello del Vangelo dei detti oppure della raccolta Q (denominata Quelle, fonte, dagli esegeti germanici), da cui originano più articolati scritti evangelici: i quattro (Matteo, Marco, Luca, Giovanni) in seguito riconosciuti come canonici dalla Ecclèsia.
Francesca Penazzi
(continua)