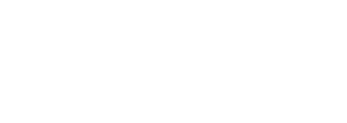L’APPROFONDIMENTO – Parola di Dio (IV)
E, sempre secondo il Concilio Vaticano II, corretta interpretazione vuole inoltre si consideri il genere letterario del testo biblico in una con il contesto storico culturale (e quindi anche personale) dell’agiografo (Sitz im Leben: alla lettera: ‘posto nella vita’, contesto cioè in cui è sorta la tradizione orale e poi scritta) peraltro a sua volta sovente ignoto o incerto o destinatario di attribuzione virtuale (in misura del pari incerta) spinta dal desiderio di conferire massima sacralità e autorevolezza allo scritto (e.g. Mosè, Davide, Salomone, Paolo …) ovvero soggetto in effetti sempre e ancora anonimo nonostante denominazione condivisa (e.g. Marco, Matteo, Luca, Giovanni …).
Per questo motivo, specifica la Dei Verbum, anche circa affermazioni con implicito significato etico occorre nella sacra scrittura distinguere la parola di Dio dal contributo degli scrittori sacri ‘veri autori nel possesso delle loro facoltà e capacità’.
E, potrebbe utilmente aggiungersi a chiarimento, altresì nel possesso della loro personalità in generale che si estende, absit iniuria verbis, pur a difetti e mancanze posto che lo Spirito, oltre a lasciare intatta la libertà della singola persona coinvolta e destinataria della specifica ispirazione in materia di fede e morale (causa humanae salutis), non la preserva, di per sé, dalla possibilità di errore altrove.
Scenario interpretativo (a parte fondamentalismi e semplicistiche soluzioni non di rado in palese contrasto con la realtà che producono corti circuiti empirici quali e.g. terra piatta, sole roteante intorno alla terra, date della Creazione etc) denso di visioni e di spunti non omogenei i quali, nella pratica e in virtù della vastità di generi letterari veterotestamentari, possono anche cooperare a seconda dei casi.
Nello Antico Testamento il filo rosso della parola di Dio, la Verità, non pare sempre agevole da individuare se (oggi) ci si ferma al puro e semplice significato (odierno) proprio di parole (umane) tradotte (oggi) da lingue e culture differenti (semitiche) il cui nastro storico di riferimento risale, per i primi rotoli, a circa 2000 anni a. C. (o ante E.V., Evo Volgare come preferisce chi intende evitare riferimenti alla nascita di Gesù): viaggio di Abramo verso Canaan, ma ancora più indietro secondo la cronologia interna biblica che prenderebbe inizio dalla Creazione e da Adamo.
Per stare alla parte più antica (Toràh, Pentateuco), a Genesi ed Esodo sono accreditate tradizioni orali fra il ‘950 e il ‘700 a. C., compilazione nel ‘700, redazione definitiva nel ‘400; al Levitico compilazione nel ‘500-400 e redazione definitiva nel ‘400; a Numeri come Genesi ed Esodo; al Deuteronomio compilazione nel ‘700 a. C. e redazione definitiva nel ‘400.
Nel periodo dal 875 a.C. al 852 a.C. si colloca la vicenda del re Achab, indotto dalla moglie cananea ad abbandonare Dio per il culto dei Baal, e del profeta Elia: anche questo caso termina in strage gestita dal Signore e nella liturgia cattolica la usuale chiusa della lettura, Parola di Dio, induce forse qualche disorientamento in chi, fra i partecipanti all’Eucarestia, ha ascoltato o conosce il passo. Non dissimilmente da quando Giosuè, in battaglia contro i cinque re degli Amorrei, ferma il sole e la luna e non come taluno inzucchera dal pulpito per mettere in fuga i nemici, peraltro già martellati dalle pietre della grandine a opera di Dio, ma proprio per ucciderli tutti: finché il popolo non si vendicò dei nemici […] perché il Signore combatteva per Israele.
Quindi, storicamente, la genesi e l’elaborazione dei primi cinque rotoli si colloca mediamente fra un secolo (‘700) che, al nord, vede la distruzione del regno di Israele e di Samaria a opera degli Assiri (epoca dei profeti Amos, Osea, Isaia, Michea) e, al sud, nel regno di Giuda l’assedio senza successo di Sennacherib a Gerusalemme e un altro secolo (‘400) caratterizzato dal governo persiano e, tornata una parte degli ebrei da Babilonia, dalla costruzione del secondo tempio, missioni di Esdra e Neemia a Gerusalemme e riforme religiose (epoca degli ultimi profeti Aggeo, Zaccaria e Malachia).
È, questa, una fascia di tempo molto importante nella storia politica e religiosa degli ebrei e torna in mente, anche a proposito del Pentateuco, il pensiero di Pascal già riportato: […] un libro che viene fatto dal popolo stesso.
Ove il ‘popolo’ che lo fa, lo scrive, è in particolare costituito dagli scribi al servizio del governo, come peraltro nelle altre varie organizzazioni statali del tempo, i quali in Israele si confrontano con i re (o, in epoca persiana, con i governatori), i sacerdoti e i profeti che non sono solo quelli poi riconosciuti canonici, ma anche quanti variamente accusati di falsità per essere al servizio più del potere che di Dio.
Ecco perché si può parlare di ricerca del filo rosso della parola di Dio nella scrittura veterotestamentaria considerando come, per il credente, l’ispirazione di Dio sullo scrittore sacro sia bensì presente, ma non sempre in ogni sua parte di opera (e.g. in narrazioni e vicende storiche) e vada individuata con approfondimento che, lungi da interpretazioni unicamente letterali o fondamentaliste, sia viceversa alla luce storica, letteraria e teologica e in grado di portare alla superficie proprio quella tematica di fede e morale (causa humanae salutis) da considerare ispirata, vale a dire Verità.
Il ragionamento vale, inoltre, una volta che si sia individuata anche quale figura di Signore considerare: quale cioè nella rivelazione evangelica di Gesù oppure, quale precedentemente nelle vesti di celeste sovrano più potente di ogni altro e condottiero geloso oltre che con la folgore pronta in mano.
Se è vero che il Nuovo è compimento dello Antico Testamento e a parte che l’Altissimo è sempre il medesimo sebbene diversamente intuito nel tempo, dovrebbero emergere allora lineamenti più di Iddio abbà piuttosto che di Iddio Yahweh (riferimento solo cronologico) maggiormente comprensibili, questi ultimi, se rapportati a tempi per tutti i popoli spietati assai e ben più indietro nella storia.
E d’altra parte nel Credo (Simbolo niceno-costantinopolitano) è riconosciuto allo Spirito Santo di avere parlato per mezzo dei profeti onde la breve formula già può essere indicazione circa dove si trovi con maggiore certezza la Parola di Dio.
Per attualizzare meglio il concetto si può e.g. considerare la prescrizione vetero testamentaria di herem/cherem, sterminio totale di ogni essere vivente, che connota la costante violenza (e antica ferocia) della progressiva conquista di Canaan e non solo.
Come sintetizzato da Ravasi nella Bibbia ci si imbatte in almeno 600 passi che descrivono guerre, in circa altri 1.000 in cui è l’ira divina a generare morte e rovina e in oltre 100 passi ove è Dio stesso a ordinare un’uccisione.
Herem/Cherem è istituito e reso obbligatorio da Mosè nel Deuteronomio (capitoli 7 e 20), trova conferma nel Levitico (Ogni cosa votata allo sterminio è cosa santissima riservata al Signore. Nessuna persona votata allo sterminio può essere riscattata: dovrà essere messa a morte) ed è poi raccontato nella sua obbediente e pratica applicazione da Giosuè (a cominciare da Gerico) in poi.
Esso significa destinazione allo sterminio, dettata da Yahweh quale regola di guerra per mezzo di Mosè al popolo, rivolta alle popolazioni pagane della Terra Promessa, Canaan: […] Soltanto nelle città di questi popoli che il Signore tuo Dio ti dona in eredità non lascerai in vita alcun vivente, ma li voterai allo sterminio: Hittiti, Amorrei, Cananei, Perizziti, Evei e Gebusei, come il Signore tuo Dio ti ha ordinato di fare.
Questa regola segue la precedente, meno feroce e più tradizionale, che attiene alle città molto lontane (rispetto alle cananee) le quali, se non avranno inteso stipulare pace con Israele e diventare così sue tributarie, pratica internazionale corrente, una volta sconfitte per opera del Signore avranno solo gli uomini passati a fil di spada, ma tutto il resto, donne, bambini, bestiame e quanto nella città, bottino e preda: nella normalità dei rapporti socio-politici internazionali.
Il motivo obbligatorio di herem/cherem era togliere la possibilità che, abitando vicino ai pagani, il popolo imparasse a imitare i loro abomini così venendo a peccare contro il Signore.
Programma invero non facile se perfino il sommo Salomone, il più grande dei re di Israele che aveva -con saggezza sproporzionata rispetto alla sua età- domandato al Signore la sapienza di governo, invecchiando si lasciò condurre all’idolatria da parte delle numerose mogli straniere (le donne cananee citate da Mosè) e a infrangere la prima delle dieci parole della Alleanza del Sinai, il Decalogo.
Cherem è ripreso nei 613 precetti ebraici (mitzvòt), con la Mitzvà positiva 145 che prescrive: “Oggetti santificati (cherem). Tuttavia, un cherem che un uomo prometterà di mettere da parte per D-o da tutto ciò che possiede, sia umano o animale – Levitico 27:28.
Qualsiasi cosa santificata come cherem deve essere data a un kohen (sacerdote, ndr) (a meno che la persona precisa che è ‘cherem per Hashem (il Nome, vale a dire il Signore, ndr)’, in tal caso deve essere donato alle casse del Tempio)”.
La regola antica sul voto di sterminio appare quindi già modificata e alleggerita nell’ebraismo così come nella lettura cristiana che utilizza modalità interpretative storiche, letterarie e teologiche.
Nondimeno l’opzione fra lettura biblica letterale e fondamentalista o lettura alla luce ermeneutica storica, letteraria e teologica non è poi così scontata né sicura come potrebbe sembrare considerato che adottano la prima, con tenacia e convinzione, non pochi movimenti riformati cristiani esistenti, particolarmente negli USA, oltre ai testimoni di Geova, e in Israele movimenti e partiti religiosi ultraortodossi e oltranzisti i quali, oltre a tutto, fanno pure parte essenziale del governo di Tel Aviv.
Fra costoro si contano coloni che, a proposito dei palestinesi, dichiarano convinti se ne debbano andare via oppure morire in loco e ministri in carica come recentemente quello che, ispirandosi a Erode e sulle tracce del rotolo di Giosuè, si è candidato a occuparsi dei bambini palestinesi (fino a ora ne sono morti per la guerra circa 19.000) uccidendo direttamente i rimasti che ce ne sono rimasti sempre troppi.
Ed è ancora al suo posto, lui e non solo lui: i firmanti da parte di Israele della attuale pace.
Francesca Penazzi
(Le prime parti dell’articolo sono state pubblicate sui precedenti numeri 241, 242 e 243)