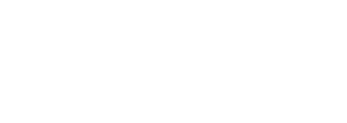L’EDITORIALE – Dalla sudditanza alla cittadinanza: il giudice come garante della libertà
A cosa serve, detto in due parole, una magistratura (realmente) libera e indipendente?
A dividere l’Ancien Régime, lo Stato Assoluto, il Leviatano di Hobbes che assorbe ogni singolo individuo -non cittadino, ma suddito- dal Nouveau Régime caratterizzato dalla separazione dei poteri, schema che, lì per lì, non ebbe per nulla vita facile tanto che il suo autore, Montesquieu, dopo averlo pubblicato (anonimo) nel 1748 (De l’esprit des lois, Lo spirito delle leggi) ritenne opportuno far seguire, nel 1750, la Défense de l’Esprit des lois (Difesa dello spirito delle leggi). All’ex suddito, divenuto libero cittadino, sarebbe poi stata di lì a breve offerta da Tocqueville anche la prospettiva di assenza di ceti sociali protetti e il riconoscimento di una sostanziale uguaglianza priva di privilegi di nascita e di censo (democrazia).
Questo è, più o meno, lo schema (ancora) dello Stato liberal-democratico occidentale oggetto di critiche erosive e strattonamenti svariati già al suo interno, per non dire dell’ostilità manifesta di larga parte del mondo esterno da sempre persuaso della superiorità di governo della tirannide in cui la magistratura è parte integrante (e invero molto utile ai fini di mantenimento del potere e repressione di alternative) del Leviatano.
Mentre l’Italia a proposito della (necessaria) riforma della giustizia si distrae sulla separazione delle carriere (requirente e giudicante) dei procuratori piuttosto che sulla solidità ed efficacia dell’istituzione tale da garantirsi la fiducia dei cittadini, si osservi in proposito quanto sta avvenendo negli USA, Paese che entusiasmò e ispirò Tocqueville (La democrazia in America) tanto da fargli mettere opportuni puntini sulle i circa la presunta analogia della rivoluzione americana con quella francese: dalla prima nasceva la libertà, dalla seconda terrore e morte.
Ora alcuni Stati USA -Oregon, Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Minnesota, Nevada, New Mexico, New York e Vermont- hanno citato in giudizio l’amministrazione Trump (davanti alla Corte del Commercio Internazionale degli Stati Uniti, New York) per contrastarne la politica tariffaria e chiedere al tribunale di dichiarare illegali le disposte (dal principe) tariffe impedendo alle agenzie governative di applicarle.
In particolare essi contestano alla radice la legalità della politica presidenziale accusandola di essere ispirata “a capricci piuttosto che al sano esercizio dell’autorità” e di utilizzare strumentalmente e in mala fede lo International Emergency Economic Powers Act per imporre arbitrariamente dazi che solo il Congresso ha il potere di determinare.
E la scorsa settimana si è aggiunto un altro ricorso, da parte del governatore della California, che ha citato in giudizio per lo stesso motivo di politica tariffaria l’amministrazione Trump presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti in California contestando che il suo Stato, il più grande importatore del Paese, potrebbe perdere miliardi di dollari di entrate.
Secondo il portavoce della Casa Bianca l’amministrazione “rimane impegnata ad affrontare questa emergenza nazionale -che sta decimando le industrie americane e lasciando i nostri lavoratori- con ogni strumento a nostra disposizione, dalle tariffe ai negoziati” e quindi, a fronte di un perdurante dialogo fra sordi, al taikùn è giudiziariamente contestato di agire né più né meno come un antico monarca legibus solutus.
Per cui l’azione è necessariamente giudiziaria, sul piano politico non essendoci forza veruna di contrasto, onde la magistratura diviene ed emerge come l’unico mezzo non violento per la soluzione della crisi e l’unico baluardo per la salvaguardia della legittimità dei comportamenti politico-amministrativi.
Nel merito lo International Emergency Economic Powers Act, vale a dire la legge del 1977 cui Trump si appella per dichiarare l’emergenza economica e attuare i dazi, prevede che il presidente possa agire in autonomia solo in risposta a “minaccia insolita e straordinaria” proveniente dall’estero: in tale caso la legge gli consente di bloccare le transazioni.
Ci sono già state emergenze attive ai sensi della citata legge come le misure adottate per rispondere alla crisi degli ostaggi in Iran del 1979, alle violazioni dei diritti umani in Venezuela, allo sviluppo di armi nucleari in Corea del Nord e a molteplici azioni intraprese da Cina e Russia.
Ora il presidente, sconfessando il suo dichiarato obiettivo di ridurre l’inflazione nazionale (e a parte il subbuglio nell’economia mondiale di cui all’evidenza non si cura), sostiene che i dazi contro Canada e Messico, peraltro a loro volta motivo di ritorsioni da parte di entrambi i Paesi sulle importazioni statunitensi, sono volti a fermare l’immigrazione illegale e il commercio illecito di fentanyl come del pari i dazi contro la Cina sono per fermare la produzione di fentanyl ivi fiorente.
In particolare precisa che (Messico) i trafficanti di droga e il governo del Paese “hanno un’alleanza intollerabile” la quale “mette in pericolo la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, e dobbiamo sradicare l’influenza di questi pericolosi cartelli“. Inoltre (Canada) che i cartelli messicani stanno operando in quel Paese e sostiene, nonostante il modesto volume di fentanyl intercettato alla frontiera, che la quantità sarebbe sufficiente per uccidere “9,5 milioni di americani“. Quanto alla Cina afferma che il governo del Paese fornisce un “rifugio sicuro” alle organizzazioni criminali per “riciclare i ricavi derivanti dalla produzione, spedizione e vendita di oppioidi sintetici illeciti“.
Premesso che il problema del fentanyl è sciaguratamente drammatico, le contestazioni mosse concernono l’efficacia reale in sé dello strumento (il dazio) in rapporto sia al fatto che le motivazioni addotte non siano suffragate nemmeno dai rapporti ufficiali dello stesso governo degli Stati Uniti sia che l’azione abbia de facto colpito l’economia nazionale con aumenti di costi difficili da quantificare, ma senza dubbio molto rilevanti (è stata fatta una proiezione, non si sa quanto realistica rebus sic stantibus, a più di 1 trilione di dollari in 10 anni) e che in ogni caso sia attuata senza l’approvazione del Congresso.
Inoltre, per sua stessa ammissione, il presidente appare conscio della possibilità di “un po’ di dolore” sotto forma di inflazione più elevata, perdita di posti di lavoro e crescita rallentata.
Non esattamente nell’ambito delle (ancora) fresche promesse elettorali, ma si sa che il vizietto della memoria corta è diffuso ovunque.
E peggio ancora, ma è valutazione politica che sfugge all’esame giurisdizionale, oltre alle ragioni -legali o illegali si vedrà- dichiarate, il presidente palesa sorprendente ammirazione e fiducia per il sistema dei dazi in generale sostenendo che essi renderebbero gli Stati Uniti più ricchi sebbene a prezzo di aumenti di tasse trasferiti a consumatori e imprese sotto forma di prezzi più alti.
Si vedrà dunque come sceglierà di agire e sentenziare la magistratura adita, avendone anche il coraggio perché il soggetto, permaloso e vendicativo, ha già messo in riga gli ultra potenti magnati della Silicon Valley e taluni fra i più forti ed efficaci studi legali del Paese a lui stesso poco graditi.