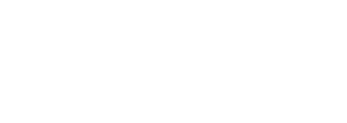L’EDITORIALE – Evangelo: dalla voce del potere alla parola che cambia il mondo
E’ noto, se non altro per sentito dire, che il termine vangelo o evangelo significa ‘buona notizia’ così come espresso dall’identico originale greco: ‘bene, buono’ (èu) e ‘annunziare’ (agghèllo).
Coerentemente la persona che porta l’annuncio è ‘angelo’ (àgghelos) e il termine è riferibile sia al messaggio annunciato sia al soggetto che agisce onde, a esempio, all’Angelo compete la funzione di essere messaggero del Signore.
Basti ricordare l’annunzio a Maria e all’anziano futuro padre di Giovanni (Battista), Zaccaria, da parte dell’angelo Gabriele (secondo Luca) o l’anonimo angelo che interloquisce con Giuseppe al tempo del suo fidanzamento con Maria e della fuga e ritorno dall’Egitto.
‘Evangelo’ non è però solo sostantivo di matrice o utilizzo neo-testamentario e cristiano, ma nella cultura non religiosa dei secoli andati -precedentemente, durante e poi rispetto a Gesù- in cui il greco era usato nel mondo analogamente alla lingua inglese oggidì, euanghélion era anche, anzi era soprattutto, termine laico politico-burocratico indicato per qualificare, sottolineandone il valore, un annuncio ufficiale molto importante presso coloro che ne sarebbero stati destinatari.
In assenza dei moderni media e di social cui si affidano, con alterna fortuna, i grandi di oggi, dipendenti dall’assuefazione comunicativa che li spinge a messaggiare non solo ‘bene, buono’, ma tutto, l’evangelo corrispondeva alla notizia che si riteneva di diffondere tramite appositi messaggeri.
Nel mondo greco c’erano corridori specializzati, pony express ante litteram, in grado di correre in autonomia per un intero giorno (denominati emerodromi).
E nella più istituzionale e burocratica realtà quotidiana dei tempi, questa buona notizia (evangelo) da comunicare all’impero, ai sudditi e a chiunque urbi et orbi era decisa dal vertice del potere costituito (imperatore, re, legati, procuratori) per messaggi che tutti dovevano necessariamente conoscere: vittorie, conquiste, avvenimenti ad alto livello come nomine, matrimoni, nascite importanti etc).
Secondo una tradizione che risale a Plutarco e a Luciano, per esempio, il soldato Filippide (nome incerto) nell’estate del 490 a. C. corse filato da Maratona ad Atene in ansia per comunicare la non scontata vittoria greca sui Persiani e, fatto appena in tempo a dire ‘Abbiamo vinto’ (Nenikékamen), morì stroncato dalla fatica. Fu indubbiamente prototipo circa il portare la buona, buonissima notizia.
Era quindi sostanzialmente un termine, un sostantivo di natura politica per la comunicazione ufficiale dall’alto in basso, dai vertici al popolo.
E’ quindi ben singolare che uno sconosciuto giudeo (illustre incognito, si suole dire) con nome ebreo, Giovanni, e un altro (detto Marco) latinizzato e fra i più diffusi e comuni del tempo, inopinatamente si appropri di un termine tanto ufficiale e altisonante per dare solenne principio a uno scritto che riguarda un altro del pari sconosciuto giudeo, a sua volta portatore di un nome comunissimo, Yeshua, e semplice figlio di uomo: uno non diverso dalla moltitudine priva di qualsivoglia segno, seppur minimo, di riconoscimento.
Marco, in un mondo bilingue greco-latino, scrive attendibilmente a Roma nel periodo fra la persecuzione di Nerone (64 d. C.) e la distruzione del tempio di Gerusalemme (70 d. C.).
Scrive, a detta degli esperti, dapprima in lingua aramaica o ebraica e poi traduce in un greco, elementare e composto di una manciata di parole in tutto, rivolto a chiunque e atto a farsi comprendere da chiunque, ma è abile compositore di frasi al contempo semplici e poetiche e suggestive con le quali esprime compiutamente il modo di pensare semitico che è alieno, a differenza di quello greco-latino, da astrattezze e speculazioni teoriche.
E cosa scrive?
Fissa sul papiro l’esperienza di un altro uomo, a sua volta senza segni particolari e un passato da pescatore, di nome Simone ri-nominato Pietro, che non comunica idee, giuste o meno giuste, ma fatti, così come sono capitati a uomini e donne qualsiasi neanche tanti anni primi nella turbolenta, e ai Romani sempre sospetta, lontana Giudea.
E così facendo smonta errori ed eresie degli uomini verso Dio, cioè la falsa e ipocrita immagine che gli uomini (si) fanno di Dio a loro immagine e ad usum delphini.
La realtà, il modo per conoscere quel Dio che nessuno ha mai visto è un uomo, Gesù, un essere uguale agli altri che si definisce figlio di uomo, come tutti.
La differenza però rispetto a tutti è che apre una (la) strada, ama il prossimo, ne ha compassione, ne accetta i limiti, non condanna, va incontro a chiunque, non dubita e addirittura testimonia quanto dice dando la vita per amici e nemici.
Da questo uomo, dal suo esempio e dal suo non paludato insegnamento per parole semplici e fatti essenziali, intorno al mistero del quale Marco racconta e al contempo si domanda e domanda a chi legge, nascono i diritti fondamentali della creatura umana: dignità dell’essere in quanto tale, parità della donna, separazione fra Dio e Cesare e, in tre uniche brevi parole, i valori fondanti di pace, giustizia e libertà: di lunghissima e faticosa e non ancora realizzata maturazione nei secoli.
Non è difficile immaginare la sorpresa, lo sconcerto, l’incredulità, la meraviglia di coloro i quali, liberi o schiavi, si trovarono un giorno di fronte a questo sobrio e lapidario incipit che sovvertiva e usurpava l’uso e la funzione tradizionale (forse fin troppo nota) degli evangeli del potere.
Per coloro che erano in grado di leggere e per coloro i quali ascoltavano dalla voce altrui.
Chi è dunque questo uomo?
E nel confondimento del pensiero, in qualcuno principiò a germogliare la speranza di qualcosa di buono.
Nessuno ha più aggiunto uno iota e il mondo, volente o nolente davanti agli occhi dei suoi millantati e millantatori padroni pro tempore, è cambiato per sempre.
Il vangelo, la luce nel buio, la buona notizia, la via del regno, il mistero di Dio.