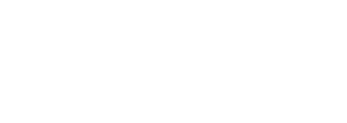L’EDITORIALE – L’astensione che uccide la democrazia
Lo sconcerto che molti cittadini (e forse non solo in Italia) provano davanti alle modeste esibizioni di una classe politica in genere largamente deficitaria sotto il profilo sia morale sia materiale, oltre a incertezza e timore per il futuro, allontanano per delusione e impazienza dalla politica cui sono addebitate in toto le incapacità e malefatte dei suoi attori.
Il corto circuito è in realtà comprensibile, e in qualche misura anche giustificato dalla spontaneità della reazione, poiché nelle istituzioni la qualità e la differenza sono fatte, in gran parte, proprio dalle persone, ma la protesta pur fondata non dovrebbe distogliere l’attenzione dalle sue conseguenze: l’allontanamento e anche il disprezzo per l’istituzione è esattamente l’obiettivo ultimo che si pongono gli avversari dell’istituzione, coloro che intendono impossessarsene utilizzando la rinuncia della maggioranza delusa e irritata defluente in una sorta di progressiva accidia politica.
Oltre certi livelli della quale calano o sono calate barriere di non ritorno.
Al riguardo sono individuabili, nel passato remoto e recente sia delle collettività socio-politiche sia anche dei singoli, esempi di ogni tipo: dalla perdita della libertà di un popolo che ha tra-lasciato la propria responsabilità permettendo all’autocrate di turno di intronarsi (a volte perfino -quale derisione!- saltando sul treno in corsa di un’ultima tornata elettorale) alla perdita di mobilità psico-fisica personale di colui che, per qualsivoglia motivo, si lasci condurre dalle circostanze sul binario morto della propria vita.
Un non dimenticato grande giornalista suggeriva di votare turandosi il naso, ma in ogni caso di votare e il buon consiglio potrebbe oggi essere integrato dall’avvertenza del trattenere non solo il naso, ma anche sguardo e udito: comunque e sempre votare e continuare a votare perché il binomio democrazia-libertà non è (mai) un dato acquisito quanto piuttosto un risultato ottenuto o una conseguenza coltivata.
E ogni coltura va protetta da infestanti e parassiti non dimenticando il teorema di Tucidide a mente del quale la costante dell’uomo essendo la sua brama inesauribile di potere, questa non può essere contrastata se non da forza uguale e contraria.
Solo per inciso, la (ricorrente) polemica circa la migliore opportunità di andarsene al mare piuttosto che al voto, diatriba che ha la coda lunga in quanto non solo di oggi, non è da prendere, come potrebbe sembrare, al pari del solito stucchevole battibecco: dato che ogni volta le parti pro e contra cambiano ruolo senza distinzione di colore: chi gridava sì ora grida no e viceversa.
No; più il tempo passa e ci si allontana dal dicembre del 1947 e dallo spirito dell’Assemblea Costituente più aumenta la tentazione di presentare forme di involgarimento e svilimento del voto, tentazione furbesca peraltro poiché è la votazione come istituto in sé a non essere nelle corde né di sovranisti né di populisti per i quali, a parte una certa preferenza per le votazioni plebiscitarie a risultato sicuro, più la gente diviene assenteista e ri-volta ai fatti suoi e meglio è.
Il minimo da raggiungere, il quorum, per la validità della votazione referendaria (l’art. 75 Cost. richiede la partecipazione al voto della maggioranza degli aventi diritto) è all’evidenza un presidio pro-democrazia (analogamente al numero legale nelle assemblee), dato che si tratta -nel caso- di abrogare norme formulate dal Parlamento, e una decisione che provenga dalla maggioranza dei cittadini appare più conforme al corretto e fisiologico funzionamento del sistema democratico rispetto a un risultato del medesimo tenore che provenga da assenteismo (disinteresse) e cioè motivo di non raggiungimento del quorum medesimo.
Fra l’altro è indicativo che sia speso maggior tempo a questionare circa il recarsi o non recarsi al seggio piuttosto che, nella specie, ad approfondire i contenuti dei cinque quesiti referendari.
Il contrasto verso l’autocrazia, in qualsivoglia forma essa intenda manifestarsi, non è (solo) un problema di confronto politico, ancorché ad alto livello, ma una precisa oltre che necessaria azione etico-politica di competenza di ognuno per la difesa di valori fondamentali della civilizzazione umana che coincidono con quelli evangelici dai quali è originata la cultura occidentale: libertà, dignità e giustizia che se da noi sono (imprudentemente) dati (quasi) per scontati, sebbene ancora qualitativamente migliorabili come ogni cosa, difettano però totalmente in buona parte del mondo.
E la formula del contrasto avviene per e con l’esercizio cosciente e consapevole del diritto politico e dovere civico del voto il cui continuo indebolimento degli ultimi anni dimostra una progressiva presenza luetica: nelle ultime elezioni politiche (2022) l’affluenza è stata la più bassa a livello europeo e il partito che ha vinto ha registrato una preferenza del 26% sul 64% di votanti, cioè circa 16 cittadini su 100.
La autocrazia moderna non si presenta di norma, in Occidente e quantomeno al suo inizio, come tale, cioè come essa è e vuole essere nella realtà, ma opera ‘democraticamente’ allo scopo di creare un sistema sufficiente a erodere e svilire, depotenziandole progressivamente, norme e comportamenti democratici più ancora dall’interno che dall’esterno.